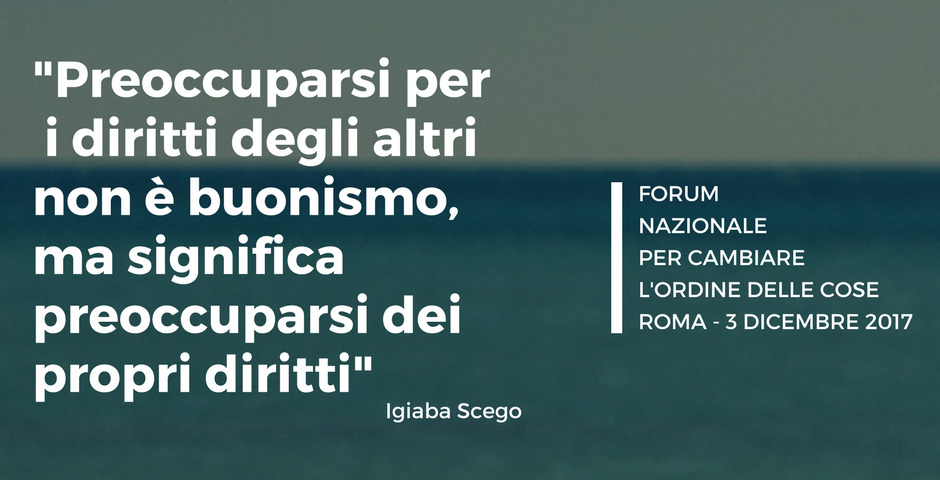A partire dall’Emergenza Nord Africa nell’ormai lontano 2011, il nostro paese ha concentrato, per forza di cose, le proprie energie e l’attenzione sul salvataggio in mare dei migranti e sulla prima accoglienza. Sacrosanto. Abbiamo, però, continuato nel corso di questi anni, quando era ormai evidente e sotto gli occhi di tutti che non eravamo più davanti ad un’emergenza profughi, bensì ad un fenomeno strutturale dovuto a diversi fattori che qui non staremo ad elencare, a mettere in atto lo stesso approccio.
Sebbene lo scorso 8 novembre, durante la presentazione della “Relazione sulla tutela della salute dei migranti e della popolazione residente” alla Camera, sia stato dichiarato che l’emergenza migratoria è finita, [[Sofia Cecinini, “Accoglienza dei migranti: 2017 anno all’insegna delle risposte strutturali”, Sicurezza Internazionale, 11 Novembre 2017 [online]. Disponibile all’indirizzo: http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/11/11/accoglienza-dei-migranti-2017-anno-allinsegna-delle-risposte-strutturali (ultimo accesso: 21/11/2017)]] di fatto tante persone sono ancora stipate nei nostri centri di accoglienza.
Per accoglienza intendiamo il lasso di tempo che va dal momento immediatamente successivo alle prime cure dopo lo sbarco e le procedure amministrative iniziali, fino all’espletamento dell’intero processo della domanda d’asilo, il quale arriva a durare uno, due anni e anche più. A queste persone in accoglienza seguitiamo, molto spesso, ad assicurare solo i bisogni primari, senza porci tante domande su quello che ne sarà di loro, poi. Se mettiamo da parte gli esempi virtuosi, generalmente osserviamo che ove sono presenti i servizi per l’integrazione, la qualità degli stessi non sempre è elevata, oppure a beneficiarne sono solo una parte dei migranti ospiti all’interno delle strutture.
Appare evidente che è a lungo mancato, o è quanto meno carente, un interesse vero e reale nei confronti della vita di queste persone e dei loro piani per il futuro.
Quell’interesse che spinge ad interrogarsi su quali siano le condizioni reali dell’accoglienza e se esse operino concretamente a beneficio di coloro che ne usufruiscono. Eppure, la questione è sotto gli occhi di tutti, di chi lavora nel settore – e dunque, se capace di conservare buon senso e sensibilità, consapevole della necessità di un cambiamento – ma anche dei comuni cittadini, bombardati dalle notizie riportate nei quotidiani e nei telegiornali, e protagonisti di incontri quotidiani con i migranti. Poche, finora, le voci coraggiosamente levatesi con l’intento di ripensare l’accoglienza e proporre in merito una riforma seria e strutturata. Cos’è, dunque, questa strana tendenza a fare finta di niente? E’ incapacità di pensare, è chiusura degli occhi? Oppure è lucida volontà di non occuparsi della questione?
Forse dobbiamo iniziare a parlare di come trascorre la vita di queste persone in accoglienza, e discutere della “qualità” della loro vita. E’ possibile pensare una vita senza qualità, la possiamo considerare ugualmente dignitosa? E in base a cosa si stabilisce se un’esistenza è davvero dignitosa?
Andrea Segre, nella sua introduzione al pamphlet Per Cambiare l’Ordine delle Cose, afferma che “[…] la risoluzione dei problemi dipende dalla nostra capacità di definirli”. 1
Tentiamo allora insieme di ridefinire il focus del nostro discorso, e di volgere lo sguardo al vero cuore della questione dell’accoglienza. In Italia, non è un mistero, c’è un’accoglienza a due velocità. Se capiti in un CAS (centro di accoglienza straordinaria) è una cosa, se capiti in uno SPRAR (il Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati) è un’altra. Se poi capiti in un CAS da Roma in giù è ancora peggio.
Niente di nuovo, purtroppo, differenze nord-sud che ci sono sempre state, le viviamo anche noi cittadini sulla nostra pelle tutti i giorni, e pur tuttavia amplificate nel caso dei migranti dalla loro già precaria condizione economica e giuridica. Il Manuale Operativo per l’Attivazione e la Gestione di Servizi di Accoglienza Integrata in Favore di Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale e Umanitaria definisce lo SPRAR come una forma d’accoglienza emancipante che “[…] ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell’autonomia individuale”. 2
Essa, pertanto, dovrebbe garantire il passaggio da una condizione iniziale di indigenza assoluta e dipendenza, ad una autonoma in uscita, grazie al conseguimento degli strumenti necessari per orientarsi ed integrarsi, economicamente e non solo, nel nostro paese.
Appare chiaro, perciò, che la prima cosa da fare per migliorare il nostro sistema di accoglienza è uniformare, con provvedimento legislativo, gli standard dell’accoglienza in relazione a quanto indicato dal manuale operativo dei centri SPRAR. E’ vero, però, che negli ultimi anni l’apertura del sistema SPRAR ai richiedenti asilo, anziché ai soli titolari di una forma di permesso di soggiorno come era in precedenza, ha spesso portato a livellare al ribasso la qualità dei servizi offerti.
Questo accade, oltre che per ragioni puramente economiche o di mala gestione, anche per la mancanza di una visione organica e lungimirante del senso da dare all’accoglienza, la quale dovrebbe avere l’obbiettivo specifico, e non solo il generico intento, di agevolare il cambiamento della vita del migrante nel suo ingresso all’interno di una società del tutto nuova, a lui estranea.
Non basta, perciò, trasformare i centri esistenti in SPRAR, ma occorre rivedere la funzione di queste strutture sulla base del significato attribuito all’accoglienza. Bisogna, cioè, indagare quale sia il pensiero sottostante, a volte profondamente celato, nei confronti dell’altro, migrante e straniero, in grado di legittimare le pratiche finora messe in atto.
Torna ancora una volta il discorso sull’investimento di interesse, sulla reale intenzione a mettere l’altro in condizione di esercitare il diritto ad una vita dignitosa ed esprimere se stesso, senza costringerlo ai margini, ma rendendolo parte integrante della società. Occorre, dunque, partire dal momento di arrivo dei migranti nel nostro paese, in quel tempo preziosissimo, tuttavia fortemente trascurato, che va dalle prime cure dopo lo sbarco alle lunghe attese dell’esito della commissione per la domanda di asilo, e oltre.
Cosa è in gioco in queste prime fasi delicatissime, tra le difficoltà passate, le brutte situazioni che ci si lascia alle spalle e la speranza-diritto, a volte così fragile, di rivendicare un cambiamento? Forse il motivo degli sguardi spenti di ragazzoni alti e forti, ciondolanti nei corridoi dei centri di accoglienza senza fare niente, sta in una mancata conferma di tali speranze? Una risposta fallace, o che tarda terribilmente ad arrivare, proprio in un momento carico della naturale aspettativa e slancio che l’arrivo nel nuovo paese inevitabilmente racchiude, può avere il sapore di una sentenza definitiva: la ricerca di uno stare meglio è preclusa al migrante. Come incide questa verità sul rapporto da sviluppare con l’altro e sulle scelte di vita da compiere in Italia, quale fiducia si può chiedere se alla base c’è uno squilibrato e violento rapporto di forza? Il pensiero latente che viene imposto condanna, senza parlare: non siamo tutti uguali.
E’ necessario, allora, essere in grado di proporre un pensiero diverso, con la consapevolezza che il solo prendersi cura dei bisogni primari, sebbene sacrosanti, non fornisce una risposta soddisfacente e non aiuta a contrastare quest’imposizione di disparità. Si trasforma, al contrario, in una doccia fredda sulle speranze e i diritti delle persone, un lento soffocarle finché non si affievoliscono attraverso la riproposizione di una vuota routine quotidiana nell’estenuante e lunga attesa burocratica a cui sono sottoposte.
Deludere una speranza, abbattere nella quotidianità immobile ogni idea di cambiamento, è ribadire la subalternità, come condanna ad una disuguaglianza insormontabile e ad una perenne mediocrità, che riesce a cronicizzare, nell’apatia o nel profondo sconforto, uomini e donne. Invece, investire sulla persona dal primo momento dell’accoglienza significa tenere conto delle sue esigenze, termine con cui lo psichiatra Massimo Fagioli ha definito i rapporti umani, gli affetti, gli interessi personali e le passioni che costituiscono la personale ricerca di un individuo nei confronti della realtà circostante. 3
Esigenze sono anche l’arte nelle sue forme variegate, il sapere, la formazione e tutte quelle attività che offrono alla persona stimoli intelligenti per riflettere su se stessa e su se stessa in rapporto con gli altri, tanto da arrivare a conoscere quanto più possibile di sé e delle relazioni significative che si trova a vivere nel corso della vita. L’accoglienza delle esigenze fa leva sulle energie e le aspettative presenti, perché ciascuno sia capace di indirizzarle verso la realizzazione delle proprie aspirazioni, una volta che le necessità primarie siano state soddisfatte.
Finché la persona è (pre)occupata dai bisogni, non avrà tempo né possibilità di chiedere altro per se stessa, di migliorare la qualità della sua vita al fine di raggiungere un proprio ben-essere reale, altrimenti mai del tutto completo. Tale ben-essere è indissolubilmente legato alle esigenze.
Come si traduce, in pratica, una proposizione che possa sovvertire l’attuale ordine delle cose?
Innanzitutto, nell’istituzione dell’apprendimento linguistico obbligatorio per tutti allo scopo di iniziare sin da subito un percorso di conoscenza e consapevolezza della nuova realtà. La conoscenza della lingua è, di fatto, possibilità di orientarsi, percepire ed agire consapevolmente la propria libertà personale. Ma la padronanza della lingua è anche socialità, creazione di quella nuova rete di rapporti che sarà la base di affetti necessaria a sostenere l’incertezza del cambiamento. Si conferma la speranza di non essere soli, di ritrovare, al di là delle cosiddette differenze culturali, quel comune sentire che fa stare bene, quel comprendersi e intendersi che riconduce la diversità della storia personale di ciascuno ad un fondo umano condiviso. Si può, dunque, trovare e riconoscere un qualcosa di sé nell’altro, in quell’arte inesauribile che è il confronto. “La vita, amico mio, è l’arte dell’incontro”, recitava Vinicius De Moraes, non ci si può sottrarre.
L’insegnamento della lingua italiana, perciò, è necessario, e diventa ancor più funzionale se associato ad una serie di attività “altre” che intendono porre le persone in rapporto diretto con il contesto culturale e sociale, relativamente alle esigenze di cui abbiamo parlato sopra. Il proporre stimoli intelligenti implica la restituzione di un’immagine piena della realtà che ci si trova a vivere, non limitata alla burocrazia e all’ambito lavorativo – fondamentale, ma non sempre coincidente con le aspirazioni del singolo -, piuttosto come ambiente vitale, con la sua storia fatta di persone e di ciò che esse hanno realizzato, sentito e condiviso.
Si tratta, cioè, di rispondere all’implicita richiesta di coloro che, oltre ad un riscatto economico e morale, cercano uno scambio osmotico tra il proprio bagaglio conoscitivo e culturale e quanto di diverso propone il nuovo contesto. E dove non presenti, la curiosità e l’interesse vanno stimolati e accesi, come unica speranza di aspirare ad una libertà reale che nasce da una conoscenza onnicomprensiva di sé e degli altri, e come sola speranza di dialettica, di confronto e rapporto con il diverso, che non prenda la deriva dell’isolamento, della paura, della chiusura xenofoba e dell’odio razzista. Di pari passo all’apprendimento linguistico e all’interesse per uno sviluppo culturale e del sapere della persona, occorre pianificare una formazione professionale seria ed efficace, che rilasci attestati spendibili e compensi la mancanza di certificazioni che anche i migranti professionalmente maturi non hanno conseguito nei paesi d’origine. Tali percorsi formativi graduali, calibrati in relazione all’utenza, dovrebbero poter fornire le competenze necessarie per qualificare il singolo, in base alle sue specificità, e metterlo in condizione di inserirsi nel mondo del lavoro.
Lavorare a strumenti specifici, a percorsi strutturati ad hoc, vuol dire iniziare a vedere la questione migratoria. Vuol dire, soprattutto, riconoscere il diritto delle persone ad inseguire quell’ideale di vita dignitosa che ciascuno si porta dentro, come naturale aspirazione al proprio ben-essere. Difficile mantenerlo vivo, in un paese che rimanda l’impossibilità al cambiamento. Contro questo rifiuto reiterato nei propri confronti, attuato in diverse maniere, dalle falle del sistema d’asilo, alla burocrazia lenta, alla negazione di un diritto a migrare, i migranti devono quotidianamente provare ad opporsi. Una forma di resistenza che l’integrazione lavorativa aiuta a sviluppare – poiché permette il sostentamento economico -, ma che può e deve andare di pari passo con la restituzione delle esigenze, in grado di alimentare la consapevolezza del proprio ideale di vita, e di sapere/sentire, e dunque riconoscere, la qualità della stessa.
“Nessuno è straniero”, è il titolo della campagna che è stata lanciata qualche settimana fa in concomitanza con la manifestazione dello scorso 21 ottobre. Uno slogan bello, e forte. Al di là del significato che il termine straniero ha assunto nella lingua italiana, con valenza talora positiva e talaltra negativa, la radice della parola si ricollega al prefisso latino extra, ciò che è fuori, esterno. Come se sorgesse dal bisogno di definire confini e limiti, è la famosa soglia di cui si sente spesso parlare e che dobbiamo imparare a “controllare” perché non ci fagociti, perché l’extra non si avvicini più del dovuto. Ma il confine, come ha dichiarato la scrittrice marocchina Fatema Mernissi, ha sempre a che fare con la violenza e l’esclusione. Il termine, dunque, non è esatto. Allora forse è meglio parlare di giusta distanza, in continuo cambiamento, che è l’opposto della paura di un’invasione dell’altro.
Al contrario, essa nasce dalla consapevolezza di dove, in quel momento, lo scambio può arrivare, con l’intento, se possibile, di renderlo sempre più profondo. E’ il rispetto per l’identità umana dell’altro, che, nel momento in cui la propria è ben definita, non è più una minaccia alle personali certezze. Ma non è questo il punto. Oltre al significato, più immediato, di una fatuità e inutilità del concetto di straniero legato alla cittadinanza e alla sovranità degli stati nazionali, forse è la lettura di Camus ad orientarci. Lo scrittore non a caso sceglie il termine étranger (la radice latina del termine francese è la stessa di quello italiano) per raccontare di uno straniamento che fa smarrire il contatto con la realtà e con gli affetti, fino ad uccidere senza motivo, perché ormai non si sente più niente. Ci piace allora l’idea che nessuno sia straniero. “Nessuno è straniero”, dunque, ma siamo tutti sconosciuti. Questa è la definizione di diversità che pare più calzante, che è il cuore dello slancio alla vita, dell’inevitabile andare verso l’altro, pena l’appiattimento della propria esistenza, l’ignoranza violenta, la paura.
Concludiamo rivolgendoci ad Andrea Segre, poiché questo intervento nasce dopo aver raccolto il suo invito a leggere e commentare il pamphlet relativo al suo ultimo film L’Ordine delle Cose. Caro Andrea, siamo d’accordo su tutto quanto scrivi, tranne sul fatto che il dubbio di Corrado sia il dubbio di tutti. E siamo sicuri, ci prendiamo questa libertà, di dire che non è nemmeno il tuo. Il lavoro e l’impegno di questi anni che hai profuso nel campo dell’immigrazione ne sono la riprova. Soltanto, siamo circondati da politiche e pensieri subdoli che cercano di confondere continuamente, e allora può succedere che ci sembri di venirne un po’ contaminati, o di sentirci dei Don Chisciotte vittime di illusioni buoniste, vaneggiatori di un’utopia che non potrà mai essere. A furia di sporcare le idee pulite e coerenti e di sporcare chi le sostiene, come dice Manconi, finiscono per farti credere che potresti pensarla anche tu come loro, che alla fine non è vero che siamo tutti uguali. Invece no. Il fatto è che siamo tutti sconosciuti. E’ la bellezza di quella che Lombardi direbbe una “società diversamente ricca”. Questo è il solo modo possibile e sano di intendere il diverso, di fronte al quale, altrimenti, l’incapacità di comprendere e relazionarsi deforma la realtà e ne fa un monstrum. Non ci è permesso allora dubitare, Andrea. Siamo con te, non sei solo.
Sara Forcella
- Andrea Segre, Igiaba Scego, Luigi Manconi, Ilvo Diamanti, Andrea Baranes e Pietro Massarotto, Per Cambiare l’Ordine delle Cose. Disponibile all’indirizzo: https://lordinedellecose.it/wp-content/uploads/2017/08/Pamphlet-WEB-1.pdf (ultimo accesso: 21/11/2017)
- Manuale Operativo per l’Attivazione e la Gestione di Servizi di Accoglienza Integrata in Favore di Richiedenti e Titolari
di Protezione Internazionale e Umanitaria, a cura del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, settembre 2015, p.6. Disponibile all’indirizzo: http://www.sprar.eu/images/SPRAR_-_Manuale_operativo_2015.pdf (ultimo accesso: 21/11/2017) - Cfr. Massimo Fagioli, Bambino Donna e Trasformazione dell’Uomo, Roma, L’Asino D’Oro, 2013, pp. 122-123