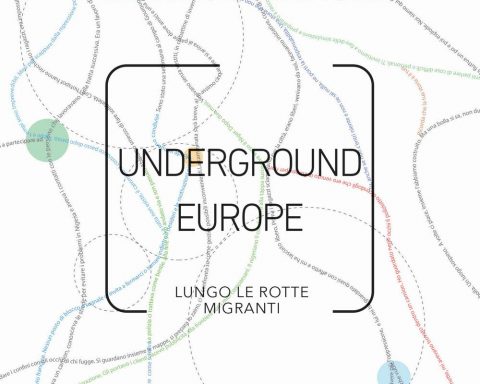Luca Queirolo Palmas e Federico Rahola, in «Underground Europe», pubblicato da Meltemi, rileggono il viaggio, il movimento, la migrazione fuoriuscendo dall’idea della vittima, del soggetto passivo facendo emergere la dimensione della lotta che sta dentro le situazioni di frontiera.
Un viaggio crudo, lungo le rotte migranti, passando per Ceuta, Melilla, Patrasso, Ventimiglia, Calais e altre borderlands europee.
Per iniziare, cosa vi ha spinto ad intraprendere questo viaggio attraverso luoghi in cui i diritti fondamentali non sembrano essere mai esistiti. Quali erano le vostre speranze, le vostre aspettative e cosa alla fine avete trovato. Quanto pesava il vostro “bagaglio” al ritorno?
Luca Queirolo: È un percorso lungo, il libro parte dal 2016 e in realtà risale a storie che rimandano all’800 americano. Noi volevamo, soprattutto, provare a costruire una storia fondata sulla ricerca, sulla nostra pratica di ricerca, che andasse a rompere o a mettere in crisi una narrazione tossica fatta di scafisti, trafficanti e violazioni dei diritti umani. Ovviamente questi aspetti esistono, ma abbiamo provato a far emergere un altro immaginario, un altro racconto possibile, che potesse fornire, anche alle decine di migliaia di persone che, in giro per l’Europa, stanno in ogni situazione di frontiera e aprono la possibilità di una libertà di movimento universale, un racconto altro entro cui inserire una miriade di pratiche disperse.
Quindi, se vuoi, tutte le diverse situazioni di frontiera che nel libro sono raccontate, portano dentro il segno di profonde violazioni e oppressioni di ogni tipo, ma anche il segno di una lotta permanente che alla fine riesce a bucare la frontiera, riesce ad aprirsi un varco ed entra dentro un territorio ricostituendolo, ripensandolo e generando anche delle pratiche di incontro, di cooperazione, delle situazioni che in qualche modo possono prefigurare un altro modo di essere Europa.
Quello che noi volevamo fare era provare a rileggere il viaggio, il movimento, la migrazione fuoriuscendo dall’idea della vittima, del soggetto passivo, della pietà, della carità, guardando invece la dimensione della lotta che sta dentro ogni situazione di frontiera, ma anche la dimensione dell’incontro ed è per questo che la metafora che utilizziamo della ferrovia sotterranea ci serve come ispirazione, perchè come diciamo nel libro è una comparazione impossibile, situata in spazi tempo totalmente diversi fra di loro.
Federico Rahola: Vorrei aggiungere che avevamo due parole da esplorare, che suonavano come bussola: da una parte l’idea di “rotte” e dall’altra l’idea di “coalizione”.
Rotte l’abbiamo inteso come uno spazio carsico, per lo più illegalizzato, ma che viene continuamente costruito e abitato. Il nostro modo di seguire le rotte – ciò che si definisce come mobilità secondaria nella prosa asettica delle contromigrazioni – è anche un modo per far vedere quanto dentro questi percorsi, dentro questo spazio che viene prodotto, ci fosse anche un modo di abitare questo spazio.
Per cui l’Europa oggi può apparire come un’enorme trappola, ma diventa anche un crocevia affollato sotterraneo e questa immagine può rovesciare quella di superficie di uno spazio sigillato, inespugnabile. Dentro questo spazio vedevamo la nostra posizione, non solo come osservatori, ma anche come soggetti politicamente coinvolti. Vedevamo formarsi dei gruppi composti da soggetti politicizzati ma molto diversi tra loro: parliamo di migranti, richiedenti asilo, soggetti in transito ingabbiati, intrappolati dentro lo spazio di Dublino, falsamente presentato poi come spazio di Schengen.
Questi gruppi eterogenei aiutavano a costruire queste rotte e ad abitare lo spazio.
Le due immagini che emergevano, in base a queste due parole, erano quelle sì di una border land, di una zona di frontiera colonizzata da dispositivi di confine, ma dall’altra la possibilità di un’altra dimensione, di un’altra idea, di un’altra immagine sotterranea che permetteva il movimento e intanto abitava questa trappola, trasformandola in un crocevia e questa era di fatto l’idea di Underground Europe.
Luca Queirolo: Uno dei protagonisti del libro, con cui continuiamo ad essere in contatto perché abita a Genova, durante una lezione ha dato questa definizione di rotta che ti vorrei leggere, perché ci aiuta per poter andare avanti nella nostra discussione:
“Fare una rotta significa andare verso nulla, senza niente, e quasi per magia arrivare a destinazione”.
Se c’è una cosa che vuole fare il libro è provare a pensare questa magia.
Che cos’è questa magia che rende possibile il viaggio? La risposta che proviamo a dare è nella cooperazione improvvisata, rizomatica, molecolare, che in tutte le situazioni di frontiera si dispiega e appunto permette, nonostante i rischi, nonostante i pericoli, nonostante le necropolitiche dell’Unione Europea, permette a decine e decine di migliaia di persone di bucare la frontiera e di provare ad andare oltre, su questo territorio di una “libertà percepita” immaginata che però in qualche modo si mette in costruzione attraverso il viaggio.
Nella prima parte del vostro “diario di bordo” – passatemi il termine – dedicata al Canada e agli Usa durante la guerra civile, aprite la sessione parlando di The Refugee di Benjamin Drew. Quanto quest’opera ha inciso nella vostra visione del fenomeno?
Federico Rahola: The Refugee narra una storia che ci sembra significativa per due o tre ragioni. Benjamin Drew fa nel 1850 un viaggio: va in Canada e va ad incontrare tutta una serie di personaggi che sono schiavi in fuga, che attraverso quella che poi verrà chiamata la via sotterranea, l’ “Underground Railroad”, accedono in Canada dopo le c.d. fugitives laws che impongono a chiunque intercetti uno schiavo fuggiasco di consegnarlo alle autorità per spedirlo alla piantagione da cui fuggiva.
Ci interessava prima di tutto la modalità di porsi. Benjamin Drew è un attivista, un abolizionista radicale, dei circoli legati a tutta una serie di figure che affollavano soprattutto il Massachusset e Boston nel 1830-40, figure davvero incredibili nella loro capacità di dialogare col mondo. La voce di Drew in questo particolare scenario è significativa perché lascia totalmente la parola ai soggetti, che raccontano da dove vengono ma senza dire cosa/chi ha reso possibile la loro fuga. Questo diventa l’elemento più prezioso della storia: la coalizione e le rotte che hanno reso possibile il viaggio e che hanno rovesciato la geografia perentoria delle catene delle piantagioni.
Non siamo di certo i primi a parlare di ferrovia sotterranea per raccontare che cosa succede a ridosso di situazioni di confine. Quello che distingue la nostra narrazione dalle altre, che speriamo di aver provato a chiarire o ad affrontare, è forse il chiedersi perché.
Perché tirare in ballo una storia del passato, che tipo di significato assume questo lavoro, che quasi va a pescare e riscatta una storia del passato e cerca, attraverso questa storia, lenti per leggere il presente. Sicuramente abbiamo cercato di dare un futuro alla promessa che quella storia conteneva. Ma l’intento è anche quello, in un certo senso, di appesantire il presente. Da secoli l’uomo lotta per processi di liberazione e lo fa costruendo rotte e coalizioni per rendere possibili questi percorsi di liberazione.
Scavando, cosa può venire fuori da questa storia? Una storia essenzialmente Black, di schiavi che hanno fatto un incredibile sciopero, disertando il sistema delle piantagioni fuggendo. Questa mobilitazione politica degli schiavi è stata l’innesco. La storia degli Stati Uniti è segnata da questo gesto di insubordinazione dello schiavo. Contro la rappresentazione ufficiale della ferrovia sotterranea come operazione invece di filantropi bianchi ispirati a ideali trascendentalisti, si tratta in realtà di una storia essenzialmente nera. Questa è la storia da riscattare, sottraendola a tutta una serie di retoriche che oggi riverberano ancora del migrante come vittima da salvare. Secondo questa retorica l’underground railroad sarebbe stata quella grande operazione con cui gli Stati Uniti di fatto si sono riscattati dal peccato originale della schiavitù, perché i bianchi hanno liberato i neri.
Se invece raccontiamo una storia attraverso una lente black, scopriamo che non c’è niente nella storia, di ciò che si può chiamare democrazia americana, che non dipenda dal contributo essenziale degli afroamericani. Quindi, forse, potremmo dire che non c’è niente nella storia decoloniale o postcoloniale dell’Europa di oggi che non dipenda dalla presenza di soggetti postcoloniali migranti e richiedenti asilo.
Dopo questa introduzione al vostro lavoro, sui motivi che vi hanno spinto e l’idea che volevate riscattare, entriamo nel vivo del vostro viaggio.
Varcate le porte di un’Europa che voi chiamate Eu-rope, intesa come campo di morte i cui confini sono tracciati da filo spinato, accampamenti di fortuna e zone di transito. Introducete il concetto di secondary movement, in relazione all’approccio istituzionale e iniziate il vostro viaggio dalla Jungle di Calais. Quale storia, quale immagine è rimasta maggiormente impressa nella vostra memoria e com’è stato ritornarci post sgombero?
Luca Queirolo: A Calais siam tornati più volte. Siamo arrivati nel momento, come dire, “dello spettacolo”: lo sgombero, quello che le autorità francesi hanno chiamato “sgombero umanitario”. Ci siamo confrontati con lo spazio del “grande campo”, forse il più grande di richiedenti, rifugiati, migranti e transitanti d’Europa (parliamo di oltre 10.000 persone).
Quello che lì ci interessava era provare a capire il perché di quello sgombero. Uno sgombero che nasceva dalla paura che quello spazio di auto-organizzazione generava nei confronti delle politiche di “gestione” dei flussi migratori. Perché il campo era, con tutte le sue contraddizioni, una città in potenza e quindi come tutte le città aveva i suoi borghesi, i suoi proletari, i suoi sottoproletari, le sue classi medie, le persone con documenti e quelle senza. Il campo rappresentava un luogo in cui si stratificavano, si affastellavano, molteplici segni di questa cooperazione possibile fra storie diverse, ma era anche un luogo attorno a cui circolavano decine di migliaia di cittadini europei, tantissimi studenti universitari, tantissimi fedeli di qualunque tipo di religione.
Era proprio questo fantasma che ha generato lo sgombero, come tentativo dello Stato di riprendere il controllo su qualcosa che non riusciva più a controllare. Il campo era, in qualche modo, un luogo sicuro per le persone che ci stavano dentro, perché permetteva, in un panorama di vulnerabilità, di avere un tetto, una tenda, un bagno (per pochissimi), delle docce, comunque dei luoghi di riposo in cui non si era soggetti alla violenza della polizia. La dinamica della vita a Calais era sempre la stessa: di notte si provava a fuggire e di giorno ci si riposava. Era possibile trovare chiese, ristoranti, saune, luoghi da ballo, posti dove praticare sport di ogni tipo e anche delle scuole. Non a caso i primi luoghi del campo che sono stati sgomberati erano proprio quelli che rimandavano a tutta la socialità che si era costruita.
Dello sgombero, quello che a noi ha colpito è stato un po’ il fatalismo e anche l’uso “opportunistico” della situazione: proprio nei momenti ultimi dello sgombero, tante persone arrivano a Calais perché sapevano che da lì potevano ricavare qualcosa. In effetti, tutti gli sgomberati, che sono stati poi riallocati nei centri in giro per la Francia, sono riusciti ad essere dei “dublinati”. Anche se avevano messo le impronte in Grecia, Italia, Ungheria e così via, sono riusciti ad ottenere pezzi di carta che legittimavano il loro soggiorno a 5-10 anni in Francia. Quindi è stata una lotta, in qualche maniera, vincente.
Lo sgombero non ha però messo fine a quella storia! Noi siamo tornati ripetute volte gli anni dopo e dai primissimi mesi dopo lo sgombero la città ha ricominciato a ripopolarsi di persone in viaggio o in transito, però in condizioni di estrema vulnerabilità. Si tratta di piccoli accampamenti, setacciati giorno e notte con l’utilizzo di cani, droni, spray urticanti, e tantissima violenza da parte della polizia, che avvelena o distrugge il cibo degli “abitanti” del posto. Quello che noi iniziamo ad osservare a Calais dall’anno successivo allo sgombero è una vera e propria caccia all’uomo, con l’idea di rendere questo spazio un luogo ostile, in cui la gente non volesse restare, perché in qualche modo le condizioni di vita andavano oltre la sopportabilità. Pure in quella condizione vediamo che i migranti continuano a sfidare la frontiera, continuano ad arrivare e a tessere relazione con il mondo delle diverse solidarietà che stanno attorno; si inventano anche altri modi di passare: per esempio, adesso lo stretto della Manica è diventato un po’ come il Canale della Sicilia e si tenta la traversata con i gommoni rubati nei porticcioli o acquistati attraverso giri diversi. Sono racconti che in parte ricostruiamo nelle pagine finali del nostro libro, quando uno dei nostri narratori ci dice
“Ho un amico inglese che ha dei kayak e insegna ai ragazzi a bagagliare per arrivare dall’altro lato”.
Quindi, nel tornare a Calais, troviamo la costruzione di uno spazio ostile, ma al tempo stesso la persistenza di una cooperazione diffusa e di un tentativo di andare verso questo spazio di “libertà percepita”.
In termini di esperienza umana, mi tornano in mente le notti in cui “provavamo” a vivere nella boscaglia con i ragazzi nelle tende.
Mi ricordo uno dei giovani con cui stavamo che aveva nascosto i suoi documenti sottoterra. Tutti quei documenti (passaporto, carta di identità, tessera sanitaria) che gli potevano essere utili per ricostruirsi una vita e di cui la polizia andava a caccia: quello che veniva fatto era distruggere la documentazione personale dei soggetti assieme ai loro telefoni.
Mi ricordo le serate in tenda prima che loro andassero al “parcheggio del diavolo”, così chiamavano il luogo in cui si provava a saltare sui camion. Mi ricordo gli ultimi giorni, che abbiamo condiviso con questo giro di ragazzi afghani che ammettevano di non riuscire a capire come avessero potuto resistere 12 mesi a Calais, perché Calais era come l’Afghanistan. Questi ragazzi scappavano dai talebani, dalle guerre di ogni tipo, molti di loro erano già seconde o terze generazioni figlie dell’esilio, per arrivare in un posto che non percepivano come molto diverso rispetto a quello da cui erano scappati. Eppure, anche in quell’“Afghanistan europeo” avvenivano delle cose che mettevano in scena questa “altra” Europa di cui abbiamo provato a raccontare.
Rimanendo in Francia, siete stati anche a Parigi, nel campo di Stalingrad nel 2016 e Porte de la Chapelle nel 2017. Cosa distingue queste realtà da Calais?
Luca Queirolo: Nell’impianto delle nostre ricerche sono delle stazioni. Stazioni di una ferrovia sotterranea che comunque emerge, si visibilizza, e risente delle dinamiche e dell’evoluzione del controllo, della repressione e delle pratiche di ricostruzione del confine da parte di attori istituzionali. Parigi è considerabile una sorta di hub, all’interno del quale arrivano diverse storie e percorsi e che rifrange altri viaggi. Nel momento in cui siamo stati a Parigi, abbiamo assistito ad un effetto “risacca”: coloro che scappavano da Calais e non accettavano di stare dentro al trattamento istituzionale da parte delle autorità francesi, ripiegavano su Parigi cercando un’altra possibilità di andare oltre, di muoversi. Ciò che risulta interessante è mettere a rilievo come questi accampamenti urbani, a differenza di Calais, si muovono dentro un “tessuto pieno”. Mentre Calais è un campo situato fuori ad una piccola città della provincia francese, gli accampamenti urbani stavano, certo ai margini, ma dentro la città di Parigi.
Un aspetto che vale la pena evidenziare è che laddove c’è un campo istituzionale c’è sempre un campo autogestito; dove c’è un campo autogestito esiste anche un processo di incontro, di solidarietà e cooperazione che si mette in piedi per varcare le maglie del sistema o per costruire altre possibilità per mandare avanti il viaggio. Sono luoghi in cui si incontrano storie anche molto diverse fra di loro.
Vorrei riprendere due passi che ci rimandano alla storia di Parigi. Per primo, sul fronte della necropolitica e della violenza dello Stato e contestata dallo Stato stesso, leggerei un rapporto del “Défenseur des droits” che racconta che cos’è uno sgombero di un campo, e dice: «verso mezzogiorno tutti i migranti sono partiti senza aver mai avuto informazioni sul loro luogo di destinazione né sul tipo di strutture dove saranno ospitati. I servizi del comune operanti in evacuazione evocavano in modo generico “un luogo dove si studierà la vostra situazione”». Questo, che è per altro un passo tratto da un rapporto istituzionale, mette in luce come dentro le borderlands europee migranti, transitanti etc sono essenzialmente “cose”, che devono essere trattate all’interno di una sorta di ingegneria logistica, in quest’ansia di gestire i flussi.
Se c’è una cosa che però il libro vuole rivendicare è il “diritto alla non gestione dei flussi”, poi altro non è se non il diritto alla libertà di movimento. Qua invece siamo in una logica in cui le persone sono “cose” e devono essere spostate e collocate in luoghi in base ad una visione della solidarietà che ha a che vedere, essenzialmente, con la “distribuzione equa” del peso della migrazione sui diversi stati membri. Quindi se da un lato i migranti sono cose, dall’altro in questi accampamenti incontriamo molte persone.
Incontriamo Safi, che arrivava da Lecce: aveva dei documenti, arrivava in aereo, poteva viaggiare. Andava a trovare dei suoi amici afghani che erano arrivati al campo La Chapelle e ci dice: “Dall’Afghanistan sono scappato perché mio padre era maestro e i talebani ci hanno bruciato la scuola. Sono qui per dare una mano ai miei amici che cercano di andare a Calais e poi a Londra. Noi raccogliamo i documenti di tutti gli Stati. Più ne collezioniamo, più abbiamo libertà di movimento. Se ci riusciamo cambiamo anche nomi, carte e identità. Adesso torno a Como a recuperare i libri che ho lasciato lì. Nella vita vorrei fare il mediatore”.
Questo per dire che, dentro queste reti che costruiscono la possibilità del viaggio, l’infrastruttura che giorno dopo giorno si costruisce, si distrugge e si ricostruisce, abbiamo storie che non rimandano solamente alla solidarietà “bianca” dei cittadini, ma troviamo storie che nascono dall’autorganizzazione spontanea di migranti di ogni nazionalità, di ogni tipo, di ogni storia e di ogni genealogia, che vanno a mescolarsi con altre storie ancora e rendono possibile scavare dei cunicoli che mettono sotto scacco permanentemente la gestione dei flussi.
La gente nei vostri confronti era diffidente? Avete avuto difficoltà a comunicare?
Federico Rahola: Il nostro modo di presentarci in quelle situazioni era definito dalla politicità delle stesse. Gli accessi sono stati resi possibili da una serie di reti di attivisti, militanti che già operavano sul territorio (mi riferisco soprattutto alla Grecia). Io sono stato in questo albergo occupato nel 2016, volontariamente sgomberato qualche mese fa, che si trova in centro ad Atene e si chiama City Plaza. La realtà composita ed eterogenea degli abitanti del City Plaza creava tutta una serie di situazioni per la quale non occorreva quasi nemmeno presentarsi. Si diventava amici facendo delle cose. Nella galassia che ruotava attorno al City Plaza o a Exarchia esisteva questo bazar a cielo aperto che si chiama Omonia, un luogo rizomatico che si insinua dentro la città in cui è possibile comprare qualsiasi tipo di documento o ticket, per chi ha risorse – altrimenti l’alternativa è percorrere a piedi la rotta balcanica. Lì, come in tante altre situazioni, esiste un’autorganizzazione di queste possibili rotte e di quello che noi definiamo come una stazione: costellazioni di soggetti che cooperano per rendere possibile il passaggio. In questo senso, Omonia Square, può essere considerata una stazione, anche per il fatto che è assolutamente non localizzabile, perché non è un luogo fisico, ma uno spazio “fantasmatico”. Le persone che gravitano attorno a questo “luogo” sono tutte persone in transito.
Luca Queirolo: È importante aggiungere che la diffidenza è giusta, nel senso che è assolutamente legittima e ognuno di noi sarebbe diffidente a raccontare pezzi di una storia così personale a degli sconosciuti. Proprio per questo la ricerca che facciamo vuole essere, non una ricerca “estrattiva”, ma una ricerca che si basa e si fonda sul fare le cose insieme. Federico abitava al City Plaza, io distribuivo colazioni ai campi a Parigi o aiutavo il gruppo degli afghani, con cui ero entrato in contatto, a passare dall’altro lato; o anche il gruppo dei kuwaitiani, da cui sono stato “adottato” durante lo sgombero del campo, a collocarsi in Francia in un qualche luogo. Tutta la ricerca che effettuiamo parte dalla creazione di una relazione quanto più simmetrica, generata dal fare insieme delle cose. Tutto ciò rende anche possibile vincere o superare dei livelli di diffidenza che sono assolutamente legittimi.
In questo lungo viaggio tra Francia-Italia-Spagna e Grecia quale realtà ha scosso più le vostre coscienze?
Luca Queirolo: È un viaggio che nasce da una cooperazione, intellettuale se vuoi. Sono due viaggi paralleli che trovavano permanentemente una stazione in cui riflettere insieme. Percorriamo l’Europa del filo spinato, dei porti chiusi, di spettacolarizzazione delle frontiere, di persone ridotte a cose, di gestione dei flussi che ci creava scandalo prima e ancora di più quando abbiamo terminato questo percorso di ricerca.
Il libro però vuole apportare una dimensione costruttiva attraverso l’immaginazione e la rilettura di questo spazio delle borderlands europee, non unicamente attraverso la lente della necropolitica che esiste, ma raccontando anche l’effervescenza, la fantasia, la politica. Quando riflettiamo sui linguaggi che vengono utilizzati dai migranti per raccontare le loro storie, nel momento in cui vanno di fronte ad una Commissione c’è il linguaggio della vittima, però esistono anche altri linguaggi che sono assolutamente fondamentali.
C’è il linguaggio dell’avventura: per molti giovani africani il viaggio è quasi come un “erasmus” per un giovane europeo, con la stessa curiosità e voglia di scoprire; poi c’è il linguaggio della guerra, perché la frontiera in qualche modo è una cosa dura, che fa male, si riproduce attraverso la violenza delle istituzioni alla quale occorre contrapporre un altrettanto disciplinata autorganizzazione per poter aumentare i tassi di successo. Nei campi che stanno a ridosso delle recinzioni di Ceuta e Melilla, troviamo tutto un linguaggio militaresco che costruisce però la possibilità stessa per i migranti di passare dall’altro lato.
Il libro prova a scavare e a vedere le possibilità, le tattiche, le strategie e anche i percorsi di immaginazione politica che nascono stazione dopo stazione e attraverso gli incontri che generano prefigurano anche la possibilità di un’altra Europa, così come la ferrovia sotterranea nella guerra civile americana, portano poi al tredicesimo emendamento.
Non sapremo risponderti su che cos’è che ci ha toccato di più, perché non c’è una risposta.
Federico Rahola: Diciamo che, voleva essere molto di più un libro di immagini, immagini che poi sono state un po’ sacrificate, ma ogni immagine di questo libro è un fotogramma di Borderland Europe, ma contiene in sé la possibilità di intravedere dietro un Underground Europe. Ricordi “Le città invisibili” di Calvino?
“Ho raccontato di tante città impossibili e infelici in cui è possibile però vedere attraverso fili di racconti dei percorsi, delle rotte, la possibilità di rovesciare queste città infelici in città felici”.
Dietro ogni immagine, spesso prodotte dai migranti stessi – spesso molto violente e crude – c’è una voce, un desiderio di raccontarsi. Ascoltare queste voci significa rovesciare la violenza di queste immagini.
C’è un’ultima foto che vorrei portare alla tua attenzione: una foto di due agenti di polizia a cavallo, una foto del 2017, che portano “al guinzaglio”, letteralmente al lazzo, un african american. Noi parliamo spesso di guinzagli, di catene, siamo arrivati a definire queste catene come un guinzaglio che governa la mobilità imponendo quella che viene definita una trappola. Per cercare la possibilità di un’immagine felice dietro le immagini infelici, serve la possibilità di recidere questa corda. Se c’è un’immagine che accompagna questo viaggio, nel passato-presente è proprio questa.
Luca Queirolo Palmas insegna Sociologia delle migrazioni presso l’Università di Genova ed è autore di «¿Cómo se construye un enemigo público? Las “bandas latinas» e, con Luisa Stagi, di «Dopo la rivoluzione. Paesaggi giovanili e sguardi di genere nella Tunisia contemporanea».
Federico Rahola insegna Sociologia dei processi culturali e Teoria dell’immagine presso l’Università di Genova ed è autore di «Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell’umanità in eccesso» e, con Massimiliano Guareschi, di «Chi decide? Critica della ragione eccezionalista».