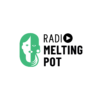Fine aprile 2019, Dawra, quartiere della prima periferia di Beirut. Attivisti migranti distribuiscono volantini per invitare alla annuale protesta di inizio maggio, in occasione della giornata internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori.
A mano a mano che si procede verso le diramazioni più esterne della città, le insegne in arabo, inglese o francese lasciano spazio a cartelli stracolmi di caratteri nuovi, densi, a volte grovigli fatti di trattini intrecciati, altre volte disegni tondeggianti, formati da ondine ritorte.
E’ proprio nei quartieri di Dawra, Nabaa, Borj Hammoud, Jnah, che si riversa la enorme, variopinta popolazione migrante di Beirut, fuoriuscita dai ranghi stretti e soffocanti della Kafala.
Kafala è la parola araba che designa il complesso sistema che regola il lavoro, la vita, e spesso la morte dei lavoratori migranti in Libano.
La traduzione in inglese è sponsorship, che dà però troppa dignità a quello che non è un sistema di leggi, bensì un insieme di pratiche e consuetudini tenuto insieme grazie al lavoro instancabile della General Security, il corpo di polizia che difende i confini libanesi.
La Kafala si basa su un contratto tra un lavoratore migrante e uno sponsor locale (il kafeel), spesso messi in contatto da intermediari, come agenzie di reclutamento o broker. La Kafala instaura un nesso strettissimo tra contratto di lavoro e diritto alla residenza: il lavoratore ha diritto a esistere e risiedere nel paese solo in quanto impiegato dello sponsor locale, e la rottura del contratto, per il lavoratore migrante, significa anche la perdita della residenza.
La Kafala in Libano vede la luce verso la fine della guerra civile, quando l’apparato statale è ridotto a brandelli, ed è troppo debole per vigilare sulle iniziative private.
Nello stesso periodo, nei vicini paesi del Golfo, l’estrazione e la lavorazione del petrolio richiedono l’impiego di qualificata manodopera straniera, che viene regolarizzata attraverso un vincolo bilaterale tra lavoratore straniero e cittadino del paese, che ne diviene sponsor. La logica piace ai libanesi, ma non c’è una eventuale rendita petrolifera a giustificare la necessità di lavoratori dall’estero. Il possibile impiego di manodopera straniera viene individuato nel lavoro domestico, tradizionalmente svolto da giovani donne che dalle campagne si trasferivano presso le dimore cittadine dei libanesi più benestanti.
Oggi, in Libano, si stima ci siano circa 250.000 lavoratrici domestiche straniere. Chi conosce il paese sa che le statistiche in Libano sono poco più che vaghe approssimazioni: con la complicità di un sistema politico che basa la divisione dei poteri su un presunto equilibrio settario, un vero e proprio censimento non si effettua da decenni. Si pensa che i libanesi siano quattro milioni, ma forse sono di più; si crede che i rifugiati siriani siano un milione e mezzo, ma forse sono di più; si conta che le donne migranti siano 250.000 ma sono certamente molte, molte di più.
La vita e il lavoro di una migrante in Libano
Meseret ha 18 anni, vive nella periferia di Addis Abeba, in Etiopia, con i suoi genitori e le sue due sorelle. A volte porta a casa qualche birr facendo lavoretti qua e là, ma anche arrabattandosi alla bell’e meglio fa fatica a raggiungere una stabilità economica. Da quando era bambina, ha visto tante ragazze come lei partire per cercare un impiego all’estero: alcune sono tornate, stanche e invecchiate, però ora hanno una bella casa per i loro figli. Altre sono tornate diverse, con qualche bruciatura sulle braccia, o con una gamba che zoppica. Altre ancora non sono mai tornate.
La madre di Meseret la accompagna ad un ufficio sbilenco ai margini della capitale, lo chiamano agenzia del lavoro. Pagano delle tasse non ben specificate, il prezzo del biglietto aereo, e la settimana dopo Meseret si presenta all’aeroporto, con una grande croce di legno al collo e la testa coperta dal velo bianco ricamato ai margini che usa la domenica a messa. Ha con sé una valigia enorme, con tutti i suoi vestiti meglio conservati, ma ha fatto attenzione a lasciare un po’ di spazio, per poter metterci anche i regali, quando torna.
Aeroporto, aeroporto e poi, di nuovo, un’agenzia.
L’agenzia libanese è diversa da quella di Addis. E’ un bell’ufficio, lustro e ordinato. Una porta separa la stanza principale da uno sgabuzzino, in cui una signora elegante che scandisce ad alta voce incomprensibili parole in arabo, la spinge, con uno strattone e un sorriso. Meseret e le sue compagne di viaggio trovano altre giovani donne. Alcune etiopi, Selam, Selamnash? si salutano. Visi scuri, chiari, visi orientali, visi africani. Una stessa espressione di dubbio e attesa.
Le donne etiopi costituiscono la stragrande maggioranza del numero totale di lavoratrici domestiche in Libano. Ci sono poi migranti dal Sud Est asiatico, Filippine, Sri Lanka, Bangladesh, oppure da altri paesi africani, come Kenya, Camerun e Madagascar.
Una volta reclutate dalle agenzie, che spesso hanno veri e propri cataloghi di maids da mostrare ai propri clienti, con tanto di foto, le giovani donne vengono proposte ad un kafeel libanese.
Le donne filippine, chiare di carnagione e spesso fluenti in inglese, sono considerate domestiche di prima scelta e vengono retribuite con stipendi più alti, di circa 300 dollari al mese. Nell’aberrante classifica delle nazionalità, le etiopi sono in fondo in fondo, e il loro stipendio non supera i 150 dollari.
Se le norme di base della Kafala si applicano a tutti i lavoratori migranti, uomini e donne, per le donne c’è un ulteriore regola non scritta: la residenza della lavoratrice deve coincidere con quella del datore di lavoro. L’assenza ingiustificata dalla residenza è sufficiente affinché il datore di lavoro possa denunciare formalmente la lavoratrice e rompere unilateralmente il contratto. Da quel momento la donna si ritrova ad essere automaticamente irregolare sul territorio libanese, e quindi passibile di cattura, detenzione e infine deportazione.
Le conseguenze immediate di questa condizione sono intuibili: Mister o Madam, gli sponsor, hanno tecnicamente la possibilità di sfruttare h24 il lavoro della loro sana’a (termine libanese che designa nel linguaggio popolare le lavoratrici domestiche, e che deriva, in maniera significativa, dalla radice del verbo “produrre”).
La confisca del passaporto è una consuetudine, passa da agente a kafeel, e viene riconsegnato alla lavoratrice solo quando il kafeel acconsente a rispedirla a casa. Il datore di lavoro decide se e quando la lavoratrice riceve il suo stipendio, intero o arbitrariamente ridotto, e, spesso e volentieri, per i primi mesi decurtato, perché usato per terminare di pagare il servizio dell’agenzia.
Il confinamento tra le mura domestiche determina orari di lavori interminabili, assegnazione dei compiti più disparati e, con una frequenza allarmante, episodi di violenze verbali, fisiche, sessuali, e, in casi documentati, anche di omicidio.
Per una lavoratrice domestica, la Giustizia è una chimera irraggiungibile. Anche nei casi di abusi palesi e comprovabili, una donna migrante in Libano non ha generalmente i mezzi finanziari, né accesso a una adeguata comprensione del sistema giudiziario per richiedere un intervento legale.
In mancanza di un sistema di tutela, spesso la differenza tra vita e morte, o tra condizioni lavorative dignitose e non, la fa la buona sorte di trovarsi fra le mani di un datore di lavoro un po’ più sensato o un po’ meno razzista.
Se invece decide di abbandonare il domicilio e cercare rifugio altrove, la sana’a diventa harbaneh, cioè colei che fugge, a conferma del singolare parallelismo che si può facilmente istituire tra luogo di lavoro e prigione.
Le harbanin, spesso e volentieri si ritrovano nei quartieri appena fuori Beirut, che diventano colorati e multiformi, nelle tante espressioni di un’economia sommersa ma non troppo: ristoranti etiopi, sri-lankesi, addirittura fusion (per esempio, sono tante le unioni tra donne etiopi e uomini sudanesi), negozi di merci importate da paesi africani, saloni di bellezza di tutte le fogge.
La vita continua così, in un equilibrio delicato tra la necessità di un ritorno a un’esistenza normale e indipendente, e le retate della General Security.
L’attivismo migrante
A Beirut, Adlieh è più di un quartiere. Se sei un migrante a Beirut, Adlieh significa prigione. Quello di Adlieh è il più grande centro di detenzione amministrativa della città, dove finiscono tutti i migranti in attesa di essere ripescati dal proprio kafeel o di essere deportati.
Il carcere di Adlieh è un’enclave apolide, un limbo amministrativo in cui si decide il destino di centinaia di persone che non hanno voce in capitolo. Però, se Meseret finisse lì, probabilmente, almeno una volta a settimana, riceverebbe la visita di un’amica migrante, che le porta lo shampoo e del caffè. E se si segue a ritroso il cammino di quella amica, si incrocerebbe la rete vastissima di mutuo supporto che esiste tra i lavoratori e le lavoratrici migranti nel paese, sia sottoposti al giogo della Kafala, sia “irregolari”.
Le esperienze migranti di mutuo aiuto sono sempre più numerose, e in alcuni casi raggiungono vette di attivismo politico vero e proprio. In alcuni casi, le donne migranti si riuniscono a prescindere dalla propria provenienza, come nel caso della Migrant Domestic Workers Alliance, altre volte si raggruppano per nazionalità: ci sono per esempio i gruppi a maggioranza etiope come Mesewat o Egna Legna, oppure la Cameroonian Coomunity in Lebanon, o ancora la Sri Lankan Women Society.
Ognuna con le proprie peculiarità, queste organizzazioni hanno generalmente dei tratti in comune. Spesso i loro membri si tengono in contatto con larghissimi gruppi Whatsapp, che a volte valicano i confini delle città e contano componenti in tutto il paese e addirittura nel paese di origine.
Le partecipanti si scambiano informazioni e contatti, organizzano visite alle sorelle detenute, creano nurseries informali per i loro bambini nati in barba al sistema, ospitano nelle proprie stanze le amiche di amiche che, esauste, hanno lasciato la casa dello sponsor e non hanno un posto dove andare.
Fanno pressione sulle ambasciate dei loro paesi, spesso inadempienti, a volte corrotte, perché si assumano la responsabilità dei rimpatri, o perché trattino con le autorità libanesi nei casi di abuso. Con l’aiuto di militanti libanesi alleati, organizzano manifestazioni e proteste, rischiando l’arresto, la persecuzione e la deportazione, contro il razzismo quotidiano e per la caduta, una volta per tutte, del sistema della Kafala.
La Kafala, la rivoluzione e il coronavirus
Le problematiche enormi che la Kafala porta con sé non sono ormai un segreto, sempre più organizzazioni e attivisti libanesi e internazionali cercano di fare luce sulla palese e sistematica violazione di diritti umani che si consuma quotidianamente nel paese. Nell’aprile 2019, Amnesty International ha pubblicato un report dettagliato, basato su interviste a lavoratrici migranti, nel tentativo di fare pressione sul governo.
A qualche dichiarazione dal ministero del lavoro sull’intenzione di riformare il sistema, però, è seguita l’ennesima procrastinazione.
“Con tutti i problemi di questo paese, vorremo mica occuparci delle lavoratrici domestiche?” è, alla fin fine, il succo delle risposte istituzionali libanesi.
Poi è arrivato Ottobre 2019, con la sua tanto attesa, bellissima, rivoluzione, che finalmente ha detto basta alle divisioni settarie e alla corruzione dei politici. Con la rivoluzione, poi, è esplosa la crisi economica, sempre latente, che ha portato l’inflazione alle stelle. E con la crisi economica, a sorpresa, è arrivato anche in Libano il coronavirus, che ha costretto al lock-down tutto il paese, paurosamente cosciente della latenza di un sistema di sanità pubblica.
Ancora una volta il dibattito sulla Kafala è stato posticipato, con sponsor in piena crisi economica che non si sognano di pagare le lavoratrici e che se lo fanno, lo fanno nella svalutatissima lira libanese; con tutti chiusi in casa, anche quando questo significa respirare l’aria del proprio kafeel aguzzino.
Durante la protesta a maggio 2019, centinaia di donne migranti sfilavano per Beirut cantando “Yuskut, yuskut nizam-el-kafala”, vogliamo la caduta della Kafala. E non si fermeranno prima che cada.