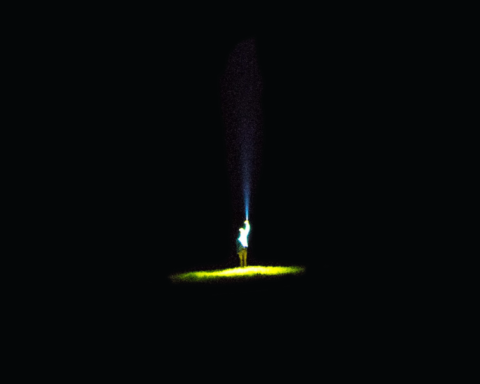In questo periodo di elezioni europee e di numerosi sbarchi sulle coste italiane si parla di Europa invocando le sue responsabilità nei confronti dell’Italia, a volte puntando il dito sulal sua latitanza, altre esaltando la sua capacità di garanzia dei diritti. Ma l’Europa che conosciamo è quella che non può fare a meno dei CIE e del confinamento, delle frontiere militarizzate e dei confini selettivi. Non c’è Europa che possa “salvarci” se non un’Europa completamente di questa che conosciamo.
Proponiamo a riguardo questo reportage di Elena Ricci sul Detention Centre di Mennoya, Cipro.
26 marzo 2014. Sono a Nicosia da più di un mese. Oggi entrerò nel Detention Centre di Mennoyia.
Lawyer’s room.
Mennoyia è l’unico centro presente a Cipro appositamente studiato e realizzato per la detenzione e il trattenimento dei migranti cosiddetti illegali, su cui pende un ordine di rimpatrio; fino al 2012 erano le stazioni di polizia a fungere da centri temporanei di trattenimento.
Anche a Cipro, la ratio che “giustifica” la detenzione è pressoché la stessa che determina il trattenimento coattivo nella maggioranza degli stati europei mediterranei e non; si viene detenuti sulla base di un ordine di allontanamento e/o rimpatrio, al fine di evitare che il sottoposto a giudizio, fugga dal territorio nazionale o che si aggiri in esso privo di documenti riconosciuti.
Il Mennoyia Detention Centre appare completamente disconnesso dal tessuto urbano principale e immerso in uno scenario naturalistico di non poco fascino. Se si rimane all’esterno.
Decidere di raggiungerlo utilizzando i mezzi pubblici è un’impresa non solo ardua, ma di sicuro insuccesso.
Ma io ho Nicoletta dalla mia.
“La mia guida” offre gratuito patrocinio ai migranti che, in linea con le garanzie previste dall’Habeas Corpus, decidono di contestare la legittimità del loro trattenimento (Law for Legal Aid, 8(I)/2012). Da anni, Nicoletta milita in un ONG locale attiva dal 1998 per il contrasto ad ogni forma di xenofobia e razzismo; si reca ogni mese a Mennoyia, però, in qualità di semplice avvocato.
Molte meno complicanze, in effetti.
Mi racconta di come le ONG locali non siano ben viste dall’amministrazione carceraria e mi narra di come i numerosi tentativi dei migranti detenuti di entrare in comunicazione con loro, vengano anzi, addirittura ostacolati.
Riesco a superare i vari check points che presenziano tutti gli ingressi, solo grazie alla sua mediazione: per affrontare la giornata senza grattacapi, mi propone un alibi da praticante avvocato ed interprete.
Così da ex-dottoranda alle prese con una ricerca finanziata solo dalla passione, vesto il mio nuovo travestimento senza nessuna rimostranza, stupita di quanto il centro somigli più ad un carcere ad alta sorveglianza che ad una struttura destinata a persone che non hanno compiuto nessun crimine, se non quello di essere fuggite da un paese in guerra o di aver cercato altrove la speranza di una vita “migliore”.
Una volta a Mennoyia, solo due gli esiti possibili: 1) rilascio, per scadenza dei termini massimi della detenzione (18 mesi) senza alcuna garanzia di status legale; 2) rimpatrio forzato.
In parole più semplici, si può scegliere (!) tra l’illegalità o l’annullamento della propria vicenda migratoria; si può tornare da dove si è fuggiti o sperare in un nascondiglio improvvisato nell’ombra, dove il prezzo della propria manodopera è misurato in 15 ore lavorative. Compenso commisurato ai desiderata del tuo nuovo “padrone” e dei ricavi della sua farm, o del suo night…
L’illegalità è l’unico modo per non tornare indietro. Almeno finché dura.
Dopo aver mostrato i documenti di identità e superato i controlli, alcune giovani sorveglianti dalle unghie ben curate e dal passo certo ci scortano fino alla stanza del Direttore, ansioso di darci il “benvenuto”.
Ci porge un centrotavola ricolmo di caramelle alla frutta e poi scrutando il mio sguardo, inizia ad incalzarmi con qualche domanda sul lavoro da avvocato in Italia; improvviso la mia parte senza nessun tentennamento. Scambia quattro battute in greco con Nicoletta e ci lascia andare, augurandoci un buon lavoro.
Nei corridoi annuso l’odore di asettico pulito e mi soffermo su una donna intenta a spolverare le targhe affisse alle porte. Nicoletta mi dice che non sono le condizioni materiali del centro (servizi, pulizia, cibo…) ad essere sotto attacco, ma le estreme violenze di carattere psicologico che colpiscono i detenuti. Spesso si viene puniti per questioni futili quali lamentele sulla qualità dei pasti; mancano servizi di sostegno psicologico e le attività ricreative o formative sono praticamente inesistenti.
Le guardie ci accompagnano ancora una volta fino alla Lawyer’s room. Nicoletta porge la lista delle persone che vuole incontrare oggi ad una delle guardie e picchiettando con le penne sul tavolo, aspettiamo in silenzio che il primo assistito varchi la porta.
Detention Centre Mennoyia, Cipro. FOTO: Elena Ricci
Una ragazza dal fisico esile e dai lunghi capelli neri è la prima ad entrare.
Arriva dal Vietnam ed è incinta da tre mesi. Sfortunatamente parla solo greco ma riesco a seguire i suoi gesti e i suoi grandi occhi scuri più di mille parole. M. è arrivata a Limassol dove è stata rinchiusa nella locale centrale di polizia, perché entrata sul territorio in modo illegale.
L’hanno picchiata sulla pancia e schiaffeggiata. Si tira i capelli e si butta per terra per simularci quello che ha vissuto.
Decidono di deportarla in Vietnam. La accompagnano in aeroporto; nel farlo le legano mani e piedi e le coprono la bocca perché M. urla, piange, si contorce.
Alla fine non parte. Minaccia di avere problemi di cuore e nessuna compagnia area pare propensa ad assumersi una tale responsabilità, mi dice Nicoletta.
Ora M. è a Mennoyia. La gravidanza procede bene. Accenna un sorriso.
Il secondo è I. un ragazzo diciannovenne del Darfur, Sudan. E’ a Mennoyia perché è accusato di aver picchiato un poliziotto in aeroporto. In realtà ci dice, ha solo risposto ai colpi che loro, per primi, gli avevano inflitto continuativamente. Legittima difesa. Ma a chi importa?
Ora è il turno di S., Iran. Arriva a Cipro nel 2004 e fa domanda per il riconoscimento di protezione internazionale. La sua domanda viene rigettata e dopo un anno viene rispedito in Iran. Torna di nuovo a Cipro nel 2006, la via più semplice per cercare di arrivare in Europa.
Ancora una volta.
Viene arrestato di nuovo e passa due anni nel tristemente noto Block 10 della Central Prison di Nicosia. Nel 2008 lo rilasciano ancora, senza alcun tipo di documento. Si sistema da amici e riesce a “guadagnarsi” qualche giornata di lavoro nero; nel 2011 la sua condizione di illegalità lo riporta nelle celle della stazione di polizia di Limassol, fino al 2012. Poi a Mennoyia, dove si trova adesso. Di fronte a noi.
“They took 5 years of my life”, ci dice, trattenendo a stento le lacrime. “I lost my life in Cyprus”.
Non riesco a proferire nessuna parola di conforto o qualche stupida espressione di circostanza che possa in qualche modo rincuorarlo. Ho di fronte un uomo iraniano brizzolato e i suoi sandali di plastica. Ho di fronte la vita spezzata di un uomo di mezza età che ha distrutto il suo passaporto per lasciarsi alle spalle ogni segno di un’appartenenza che non riconosce.
Ho di fronte la concretezza di quella Fortezza chiamata Europa e la nudità alla quale costringe chi ne contesta la sacralità.
Il report del 2013 di Amnesty International condanna la politica di Cipro per la “gestione” della questione migratoria.
Il trattenimento dei migranti è regolato a tutt’oggi dalla Aliens and Immigration Law (CAP 105), risalente al 1950, quando Cipro era ancora una colonia dell’Impero Britannico. Nonostante gli aggiustamenti normativi strutturali e sostanziali per allinearsi alle linee europee, le violazioni a Cipro sono ancora troppo evidenti.
Anche Cipro come altri stati a guardia della Fortezza Europa, è un ennesimo esempio di come il discorso sulla migrazione venga mantenuto esclusivamente sulla dimensione esterna (espulsioni, rimpatri, respingimenti, controllo dei confini) piuttosto che su quella interna (facilitazioni per l’ingresso legale, concessione di permessi di soggiorno validi, accesso alla cittadinanza).
Mi lascio Mennoyia alle spalle. Sono sulla strada di casa oramai… sento il richiamo del muezzin che aldilà della buffer-zone richiama alla preghiera…
Mi perdo nelle contraddizioni delle appartenenze ancora una volta mentre le parole di un testo di Alessandro Petti, si fanno spazio nei miei pensieri confusi:
«La macchina del confine è un’architettura interattiva. Cambia a seconda della cittadinanza di chi la attraversa» (Petti, 2007: 6).